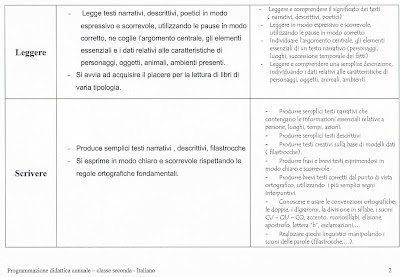Freaks: disabilità e sguardo
Bizzarro Bazar


Introduzione: quei maledetti occhiali colorati
L’immagine qui sotto è probabilmente la mia illusione preferita (non a caso già apparsa in questo blog).

Ad una prima occhiata sembra una famigliola in una stanza, intenta a fare colazione.
Eppure, quando la figura viene mostrata agli abitanti di alcune zone rurali dell’Africa, essi vedono qualcosa di diverso: una famigliola intenta a fare colazione all’aperto, ai piedi di un albero, mentre la madre sta tenendo una scatola in equilibrio sulla testa, forse per divertire i bambini. L’illusione qui non è ottica, ma culturale.
Le origini dell’immagine sono incerte, ma non ci importa qui se essa sia stata effettivamente usata in uno studio psicologico, né se sia viziata o meno da un pregiudizio di fondo sulla vita nel Terzo Mondo. La forza di questa illustrazione sta nel sottolineare come la cultura sia un inevitabile filtro della realtà.
Ricorda a suo modo un passaggio del documentario di Werner Herzog The Flying Doctors of East Africa (1969), in cui i medici si trovano di fronte al problema di spiegare alla popolazione che sono le mosche a veicolare le infezioni; mostrare grandi cartelloni con la raffigurazione dell’insetto e la descrizione dei pericoli non sortisce alcun effetto perché la gente, non abituata alle convenzioni delle nostre rappresentazioni grafiche, non capisce che sono in scala e pensa: “Certo, staremo attenti, ma qui da noi non esistono delle mosche così grosse“.

Anche se non ci piace ammetterlo, la nostra visione è condizionata socialmente. La cultura è come un paio di occhiali dalle lenti colorate, utile in molte situazioni per decodificare il mondo ma deleterio in altre, e da cui fatichiamo a liberarci con la sola forza di volontà.

‘Freak pride’ e disabilità
Veniamo dunque ai “freak”: questo termine in origine denigratorio ha assunto oggi un particolare fascino culturale, e in questo senso l’ho sempre usato con il preciso intento di combattere il pietismo e dare valore alla diversità.
Ogni volta che ho parlato di meraviglie umane, ho scoperto sulla mia pelle quanto difficile sia scrivere di queste persone.
Riflettere sul taglio più corretto da dare all’argomento significa cercare di togliersi dal naso gli occhiali colorati della cultura, un’operazione quasi impossibile. Spesso mi sono domandato se non fossi incorso anch’io in alcune generalizzazioni che non intendevo fare, se avessi peccato di involontario conformismo nel mio approccio.
Certo, ho tentato di raccontare le storie di questi personaggi stupefacenti attraverso il filtro della meraviglia: convinto che – data per scontata l’uguaglianza dei diritti – la separazione fra ordinario e extra-ordinario potesse giocare in favore della disabilità.
In questo senso ho sempre preferito quei “diversi” che hanno deciso di riappropriarsi dell’esotismo del proprio corpo, della distanza dalla Norma, in una sorta di freak pride che rigira come un calzino il concetto di handicap.
Ma è davvero il modo più corretto di approcciarsi alla diversità e, in alcuni casi, alla disabilità? Quanto di questa visione è originale e quanto proviene pedissequamente da una lunga tradizione culturale? E se il freak, alla faccia dell’orgoglio, volesse in realtà soltanto avere una vita banale, se cercasse il conforto della mediocrità? Insomma, quale prospettiva narrativa è più etica?
A instillarmi il dubbio credo che sia stata una frase di Fredi Saal, classe 1935, autore tedesco che ha passato tutta la prima parte della sua esistenza fra ospedali e case di cura perché considerato “non educabile”:
No, non è la persona disabile che avverte se stessa come anormale – è avvertita come anormale dagli altri, perché un’intera fetta di vita umana è ignorata. Dunque la sua esistenza assume una qualità minacciosa. Non ci si concentra sulle persone disabili, ma sulla propria esperienza. Ci si chiede, come reagirei se mi colpisse improvvisamente un handicap?, e la risposta è proiettata sulla persona disabile. Quindi l’immagine che se ne riceve è completamente distorta. Perché non si vede l’altra persona, ma se stessi.
(F. Saal, Behinderung = Selbstgelebte Normalität, 1992)
Per quanto io sia affezionato all’idea di un orgoglio freak, è dunque possibile che sia soltanto l’ennesima proiezione inconscia: vale a dire che mi piace pensare che io reagirei così alla disabilità… ancora una volta non mi sto veramente rapportando con la persona diversa, ma con la mia idea romantica e irreale della diversità.
Non possiamo certo guardare attraverso gli occhi del disabile, c’è un’invalicabile barriera, ma in definitiva è la stessa che si innalza fra tutti gli esseri umani. Il “cosa farei io in quella situazione?” di cui parla Saal, quel proiettare sempre noi stessi a discapito degli altri, in realtà lo si fa di continuo e non solo nei confronti dei disabili.
Il freak però è sempre stato ambiguo – o, meglio, ciò che è difficile da comprendere appieno è il nostro stesso sguardo sul freak.
Credo sia dunque importante cercare di rintracciare le origini di questo sguardo, capire come si è evoluto nel tempo: potremmo addirittura scoprire che questa cosa che chiamiamo disabilità non è in definitiva che un altro prodotto culturale, un’illusione che siamo “allenati” a riconoscere nello stesso modo in cui vediamo la famigliola fare colazione all’interno di una casa anziché all’aperto.
A mia discolpa, chiariamo subito un punto: se è possibile per me immaginare un orgoglio freak, è perché il concetto stesso di freak non arriva dal nulla, e non ha propriamente a che fare con la disabilità. Molte delle persone che si esibivano nei freakshow erano anche disabili, altre no. Non era quello il discrimine. La vera caratteristica che permetteva a quelle persone di salire su un palco era la meraviglia che suscitavano: alcuni corpi erano ammirati, altri erano in grado di scandalizzare (in quanto insopportabilmente osceni), ma chi pagava il biglietto lo faceva per rimanere stupito, scioccato, scosso nelle sue certezze.

Nei tempi antichi il monstrum era un segno divino (condivide infatti la radice etimologica con “mostrare”), che andava interpretato – e molto spesso temuto, proprio in quanto segnale di sorte funesta. Se di norma il segno mostruoso era portatore di sciagura, alcune disabilità venivano risparmiate (la cecità e la follia su tutte, considerate forme di veggenza, cfr. V. Amendolagine, Da castigo degli dei a diversamente abili: l’identità sociale del disabile nel corso del tempo, 2014).
Nel Medioevo, invece, il problema della deformità acquista decisamente complessità; da una parte la fisiognomica voleva suggerire una correlazione fra la bruttezza e la corruzione dell’animo, e in effetti la letteratura propone vari esempi di denigrazione degli avversari mediante la descrizione dei loro difetti fisici; dall’altra teologi e filosofi (Sant’Agostino in prima linea) consideravano la deformità soltanto un altro esempio della condizione penale degli uomini su questa terra, tanto che nella risurrezione ne sarebbero stati cancellati tutti i segni (cfr. J.Ziegler in Deformità fisica e identità della persona tra medioevo ed età moderna, 2015); addirittura diverse sante cristiane invocavano la deformità come prova di espiazione (vedi il mio Corpi estatici: erotismo e agiografia).
Dall’altro canto la deformità precludeva l’accesso all’ordo clericalis, sulla base di un celebre passo del Levitico in cui il sacrificio sull’altare non può essere offerto da chi è imperfetto nel corpo (P. Ostinelli, sempre in Deformità fisica…, 2015).
Il monstrum che diviene mirabile, invece, è un’idea più moderna e tuttavia nata ben prima dei carrozzoni ambulanti, prima del “One of us!” di Tod Browning, prima delle controculture hippie che se ne sono appropriate: e si oppone all’altra grande invenzione moderna nei confronti della disabilità, cioè la commiserazione.
Tutta la storia dei nostri rapporti con la disabilità oscilla fra questi due poli contrapposti, l’ammirazione e la pietà.

Il tipo giusto di occhi
All’interno della mostra Der (im)perfekte Mensch (“L’essere umano (im)perfetto”), organizzata nel 2001 dal Museo Tedesco dell’Igiene a Dresda, venivano riconosciute sei categorie principali di sguardo sul disabile:
– Lo sguardo meravigliato e medico
– Lo sguardo annichilente
– Lo sguardo pietoso
– Lo sguardo d’ammirazione
– Lo sguardo strumentalizzante
– Lo sguardo che esclude
Questa lista è certamente discutibile, ma ha il merito di proporre e tracciare delle possibili distinzioni.
Fra tutti i tipi di sguardo elencati qui sopra, quello che più infastidisce oggi è lo sguardo pietoso. Perché implica una superiorità dell’osservatore, un giudizio definitivo su una condizione che, agli occhi del “normale”, non può che sembrare tragica: è la supponenza, l’intima convinzione che l’altro sia un povero storpio da compatire. Il sottinteso è che non ci può essere fortuna, non ci può essere felicità nell’essere diversi.
Il concetto di povero storpio che (pur imbellettato con termini più politicamente corretti) sta alla base di tutte le varie maratone di raccolta fondi è ancora profondamente radicato nella nostra cultura, e porta a una visione distorta dell’assistenza – spesso più incentrata sul nostro “fare opera pia” che non sul disabile stesso.

Per quanto riguarda lo sguardo pietoso, l’esempio storico più antico di cui siamo a conoscenza è questa stampa del 1620, conservata al Museo Regionale Tirolese Ferdinandeum di Innsbruck, che mostra un falegname disabile di nome Wolffgang Gschaiter nel suo letto. Il testo racconta come quest’uomo, dopo aver sofferto di insopportabili dolori al braccio sinistro e alla schiena per tre giorni, si sia ritrovato completamente paralizzato. Da quindici anni, continua il racconto, egli è in grado di muovere soltanto occhi e lingua. L’intento del foglietto è quello di raccogliere elemosine e carità, e i lettori sono invitati a pregare per lui nella vicina chiesa dei Tre Santi di Dreiheiligen.
Questo pamphlet è interessante per più di un motivo: nel testo la disabilità viene esplicitamente descritta come “specchio” della stessa miseria dell’osservatore, dunque stabilisce l’idea che si debba pensare a se stessi mentre la si guarda; viene operata la distinzione fra anima e corpo per rinforzare il dramma (l’anima del falegname può essere salvata, il suo corpo no); si tratta storicamente di uno dei primi utilizzi dell’espressione “povero storpio“.
Ma soprattutto questo foglietto è uno dei primissimi esempi di comunicazione di massa in cui la disabilità è associata al concetto di donazione, di raccolta fondi. In pratica, un proto-Telethon che puntava sull’elemosina e sulle preghiere in chiesa per ripulire le coscienze, e allo stesso tempo uno strumento in linea con la propaganda ideologica della Controriforma (cfr. V. Schönwiese, The Social Gaze at People with Disabilities, 2007).

Di contro, già nel secolo precedente si era sviluppato un altro tipo di sguardo, quello clinico-anatomico. Questa incisione di Albrecht Dürer del 1538 mostra una donna reclinata su un tavolo il cui corpo viene meticolosamente disegnato da un artista. Fra le due figure è stato eretto un telaio con dei fili che dividono in piccoli quadrati la visione del pittore, in modo che egli possa trasporla accuratamente su un foglio recante la medesima griglia. Ogni curva, ogni dettaglio è scomposto e replicato grazie a questo stratagemma: la visione ha il primato sugli altri sensi, ed è organizzata in un quadro asettico, geometrico, di pura forma. Siamo nella fase in cui si sviluppa una vera e propria cartografia del corpo umano, e in questo contesto anche la deformità viene studiata in maniera analoga. È lo sguardo “meravigliato e medico“, in cui non si avverte alcun giudizio di tipo etico o pietista, ma la cui ideologia è piuttosto quella della mappatura, dell’intelletto che divide, categorizza e dunque domina ogni possibile variante del cosmo.
Nella wunderkammer dell’Arciduca Ferdinando II di Austria (1529-1595), conservata nel Castello di Ambras vicino a Innsbruck, è presente un ritratto davvero eccezionale. Originariamente una parte del dipinto era coperta da una tendina di carta rossa: i visitatori della collezione, nel XVI Secolo, devono aver visto qualcosa di simile a questa mia ricostruzione.

Chi aveva voglia e coraggio poteva scostare il foglio per ammirare il dipinto nella sua interezza: ecco allora comparire il corpo floscio e deforme del soggetto, raffigurato con un’estrema crudezza di dettaglio e di realismo.

Cosa gli uomini del Cinquecento vedessero in un simile dipinto non possiamo saperlo con certezza. Per rendersi conto della relatività dello sguardo, è sufficiente ricordare che all’epoca la categoria delle “meraviglie umane” includeva per esempio anche gli stranieri provenienti da paesi esotici, e una sotto-categoria degli stranieri erano i cretini che si diceva abbondassero in determinate regioni geografiche.
In libri come la celebre Opera ne la quale vi è molti Mostri de tute le parti del mondo antichi et moderni (1585) di Giovan Battista de’ Cavalieri sono messi fianco a fianco disabili e apparizioni mostruose, persone senza gambe e chimere mitologiche.
Ma la tendina di carta rossa del ritratto di Ambras è un segnale importante, perché sta a significare che un simile corpo era da una parte considerato osceno, capace di urtare la sensibilità dell’osservatore. Dall’altra gli animi più forti o curiosi potevano confrontarsi con l’immagine intera. Questo ci fa supporre che già nel Cinquecento la mostruosità si fosse almeno in parte svincolata dall’idea del prodigio, e liberata dalla superstizione dei secoli precedenti.
Il quadro è dunque un perfetto esempio di sguardo “meravigliato e medico”; dalla deformità come mirabilia all’ammirazione vera e propria, il passo è breve.

Il giusto mezzo?
Lo sguardo di ammirazione è quello che spesso ho adottato nei miei articoli. La mia pratica di scrittura e di pensiero coincide con quella di John Waters, che ha spesso ribadito di provare ammirazione per i protagonisti dei suoi film, di guardarli “dal basso verso l’alto” (looking up) e non viceversa: “Tutti i personaggi nei miei film, io li ammiro. Non penso a loro come fa la gente di fronte a un reality – che noi siamo meglio, e che dovremmo ridere di loro.”
Eppure il rischio qui è di cadere nella trappola opposta a quella pietista, cioè un’eccessiva idealizzazione. Sarà forse una mia peculiare allergia al concetto di eroismo, ma non mi interessa proporre versioni agiografiche delle vite delle meraviglie umane.
Tutte queste riflessioni, di cui vi ho fatto parte, mi portano a credere che non esista un equilibrio facile. Non si può parlare dei freak senza incorrere in qualche errore, in qualche generalizzazione, senza insomma cadere nell’inganno delle lenti colorate.
Ogni comunicazione fra noi e i diversi/disabili sopravvive in una sorta di limbo, che è l’incrocio fra il nostro e il loro sguardo. E in questo spazio non può mai esistere un confronto davvero autentico, perché dal punto di vista fisico siamo separati da un’esperienza troppo differente.
Io non potrò mai comprendere il corpo degli altri, né loro il mio.
Forse, però, questa distanza è proprio ciò che ci avvicina.


“Ognuno sta solo sul cuor della terra…”
Proviamo a considerare l’unico punto di riferimento che abbiamo – il nostro stesso corpo – rifiutando l’abitudine.
Prendo a prestito l’incipit dell’introduzione che ho scritto per Nueva Carne di Claudio Romo:
Il nostro corpo è un territorio inconoscibile.
Possiamo smontarlo, ritagliarlo in parti sempre più minuscole, studiarne le ossessive geometrie, annotare minuziosamente ogni sua insenatura su diagrammi precisi, rovistare fra le sue interiora, e il suo segreto continuerà a sfuggirci.
Ci guardiamo le mani. Passiamo la lingua sull’arco dei denti. Ci tocchiamo i capelli.
Siamo davvero noi, questo?
Ecco l’esercizio mentale definitivo, la mia personale soluzione al rebus dei freak: l’unico modo sincero e onesto che trovo per raccontare la diversità è renderla universale.

Johnny Eck si è risvegliato in questo mondo senza le estremità inferiori; suo fratello è invece emerso dal magma delle forme con due gambe.
Anch’ io sono dotato di piedi, completi di dita che posso osservare, là in fondo, muoversi appena lo decido. Sono sempre io, quelle dita? Ignoro fin dove la mia identità si spinga, e dove cominci una sua estensione.
A ben guardare la mia esperienza e quella di Johnny sono diversamente, ugualmente misteriose.
Siamo tutti fratelli nell’enigma della carne.
Questo è lo sguardo che scelgo, che mi permette di fissare il freak negli occhi senza compatirlo né celebrarlo oltre misura. Uno sguardo che non pretende affatto di mettere sullo stesso piano la mia e la sua esperienza, ma neanche di esagerare le nostre differenze.
Mi piacerebbe idealmente sedermi con lui — con il freak, con il “mostro” — sulla veranda dei ricordi, di fronte al tramonto delle nostre vite.
‘Allora, che te ne è parso di questo strano viaggio? Di questo strano posto in cui siamo capitati?’, gli chiederei.
E sono certo che il suo sorriso sarebbe simile al mio.
_____________
Per chi volesse addentrarsi nei meandri dell’etica e della politica del mostruoso, consiglio l’antologia saggistica a cura di U. Fadini, A. Negri e C. T. Wolfe Desiderio del mostro. Dal circo al laboratorio alla politica (Manifestolibri, 2001).